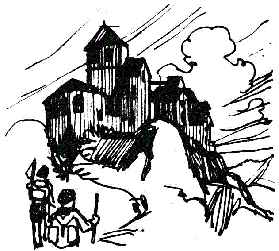Il campo a Spettine è certamente uno dei luoghi più famosi e prestigiosi dello Scautismo italiano. Migliaia di esploratori e di guide vi hanno vissuto delle meravigliose esperienze di tecnica e di spirito scout.
Il campo è situato al centro di una verde conca appenninica;
un drappeggio di bosco adorna l’imponente
edificio costruito dagli scouts piacentini, con il loro entusiasmo, con il loro impegno e soprattutto con le
loro mani.
Nella vecchia casa, sulle cui rovine è sorto l’attuale
edificio, abitava una volta un falegname di campagna che
costruiva o riparava carri, attrezzi agricoli, porte e mobili
rustici. Dal bosco, ricco di legname di varie qualità,
prendeva il materiale che gli serviva.
Era sua cura poi ripiantare i vari tipi di alberi e farli
crescere diritti.
Quella bella macchia di verde era chiamata, per questo,
«bosco del carradore». Oltre gli alberi, anzi attraverso
un varco che si apre in mezzo alle loro cime, si vedono
ancor oggi i ruderi arcigni di un vecchio castello.
Dal campo vi si può arrivare in una ventina di minuti
di cammino, salendo un ripido sentiero, che per la sua
bellezza naturale spesso è scelto dagli scouts per un’esplorazione
d’ambiente o per una veglia notturna itinerante,
con logica conclusione ai piedi delle mura del
castello, sempre un po’ misteriose, specialmente quando
la luna piena, con il suo gioco di ombre e di luci argentati,
crea una plasticità tutta medievale nel paesaggio.
Naturalmente, come ogni maniero che si rispetti,
anche questo ha una sua leggenda: immaginate che io ve
la racconti mentre voi siete seduti attorno a un fuoco e
la mia ombra si riflette e danza contro le vecchie e screpolate
mura, colorate di mistero.
Ma procediamo con ordine. Ecco alcune notizie storiche che ho trovato in un vecchio libro scritto nel 1805
da Antonio Boccia e intitolato «Viaggio ai monti di
Piacenza». Ci serviranno a fare mente locale.
«Da Ebbio a Spettine vi sono quattro miglia e mezzo.
Queste sono le più faticose e perigliose ch’io abbia fatto
da che sono al mondo. Vi sono più strade per giungere a
questa chiesa, una peggiore dell’altra e la sciocca guida
mi favorì di condurmi per la più disastrosa, circuendo il
monte dei Barbieri con dei saliscendi difficoltosi e
costeggiando per due miglia, per un sentiero poco piùlargo
di un palmo, con lo spaventevole aspetto di continue
profondissime ripe quasi a perpendicolo, sicuro
d’andare in pezzi, se il piede non avesse geometricamente
compassato il terreno. Aggiungasi che il piano del sentiero
era formato di minuti pezzi di carbonato di calce
assai mobili che scorrevano assai facilmente essendo
premuti dal piede, ond’è che conveniva appoggiarlo con
ogni cautela. La giornata era cocentissima, le ore le piùfervide
poiché dopo il mezzogiorno appena.
Il riflesso del carbonato di calcio, di cui è tessuta
quella costa, nessuna ventilazione d’aria dei seni, che
vi sono ad ogni tratto, ed il sempre presente pericolo
di andare in frantumi, aumentavano il calore più delle
circostanze.
Questa marcia fu così spaventosa e terribile, che
saputasi dai parroci circonvicini ne fecero le più alte
meraviglie.«La chiesa di Spettine è molto antica e sarà fra non
molto inaccessibile, perché dalla parte verso la Nura vi si
sale per un strada corta bensì, ma altissima, che - quanto
prima - sarà impraticabile, e l’altra strada, che viene
dalla costa già descritta, vicino alla chiesa va dirupandosi
ed è sostenuta da una specie di ponte fatto con tronchi
d’albero che poggiano su due estremità delle ripe,
che oggimai sono vicine alla chiesa».
«Contiguo alla chiesa di Spettine eravo ne tempi
passati un castello i di cui avanzi veggonsi tuttora».
Come vedete, un vero percorso da Hike!
Veniamo ora alla nostra leggenda.
Una manciatina di secoli addietro, il castello era
governato da un tristo figuro, che di nobile aveva solo il
titolo, ed era aiutato nelle sue malvagie imprese dai
figlioli. Il mestiere loro sembrava fosse quello d’imporre
balzelli oltre il limite ai contadini e ai viaggiatori di passaggio
e di godere in baldorie quegli immeritati guadagni.
Padre e figli erano una maledizione per tutti ma
poco gliene importava, tanto erano avvezzi ormai a succhiare
sangue ai poveri e a vivere di prepotenza. Forse il
nome Spettine deriva da codesta loro attività.
Un figliolo però faceva eccezione ed era, diciamo
così, la «pecora bianca», della famiglia.
Si chiamava questo figliolo Agide ed era cresciuto,
pianticella spontanea, ricco di buoni sentimenti e di
amore verso il prossimo, tanto che non potendo più sopportare
l’ambiente domestico e le villanie dei fratelli, un
bel giorno decise di partirsene per altri lidi, ove poter
respirare miglior aria.
La sua partenza fu considerata anche dagli altri una
specie di liberazione, poiché veniva così a mancare l’unica
«pietra di conforto» che in qualche modo avrebbe
potuto far ricordare l’esistenza della bontà. Dove se ne
andò nessuno lo seppe o forse a nessuno interessò.
Qualche viaggiatore, venuto da lontano, disse d’averlo
intravisto a Firenze con l’abito della
«Misericordia», qualche altro parlò addirittura di S.
Giacomo di Compostella, che era la meta ultima dei
pellegrini pieni d’amor di Dio, ma se ne parlò sempre in
termini molto vaghi ed imprecisi, tanto che dopo qualche
anno si perse anche il ricordo di lui.
Se i suoi parenti avessero avuto buoni sentimenti si
sarebbe potuto almeno giustificare codesto oblio col
proverbio «lontano dagli occhi, lontano dal cuore!» ma
qui di cuore non era proprio il caso di parlare.
Molti anni dopo in una gelida sera d’inverno, arrivò
a Spettine un viandante adorno di un ricco barbone e
avvolto in un lacero mantello, che conservava però qualche
segno di un’antica nobiltà. Non sembrava che il suo
cammino avesse una direzione precisa; chiese ad un contadino di poter dormire nel fienile e per carità ebbe
anche una zuppa calda.
Dopo qualche giorno era ancora in loco e poiché non
aveva l’aria di quelli che amano vivere a sbafo, trovò da
lavorare alle dipendenze del castello, in cambio di una
minestra e di un rifugio per la notte. Gli furono assegnati
subito i lavori più umili ed il riparo più sgangherato.
Non si lamentò mai per il troppo lavorare, anzi sembrava
che accettasse l’umiliazione in cambio di chissà
quale peccato. I cani dei padroni erano certamente tenuti
in migliore considerazione ed anche meglio nutriti.
Se poteva, se gliene rimaneva il tempo, cercava di
aiutare i poveracci come lui e quanti nei dintorni erano
nella sofferenza: lo faceva soprattutto con qualche
buona parola e con un invito a unire il proprio dolore a
quello di Gesù Crocifisso e questa sua fede otteneva
sempre maggior risultato dell’aiuto materiale, che pur
cercava di dare con le sue braccia, perché di denaro
certo non ne aveva.
L’unico momento in cui pareva uscire da un volontario
nascondimento era la mattino prestissimo, quando
si recava a Messa nella chiesa parocchiale, che allora,
come appare anche dalle cronache di Antonio Boccia
più sopra ricordate, sorgeva prossima al Castello, in un
luogo in cui ancor oggi pare di notare l’ubicazione. I
preti allora avevano l’abitudine di recarsi in chiesa al
mattino quando ancora fuori era buio e quindi quasi nessuno, tantomeno qualche abitante del castello, aveva
modo di notare questa devozione del nostro personaggio.
Un brutto giorno si ammalò e il parroco, avvertito
in tempo da qualche altro servo che conservava un po’
di compassione, corse ad amministrargli gli ultimi
sacramenti.
Il poveraccio giaceva in un mucchio di stracci, in un
sotterraneo umido che aveva tutta l’intenzione di voler
far concorrenza al giaciglio di Giobbe o meglio alla
grotta di Betlemme e proprio per questo il Signore fu molto contento di entrare in quel luogo e soprattutto in
quell’anima.
Di lì a poco morì.
I signori del castello avrebbero voluto seppellirlo
nella vigna per far concime, ma il parroco, che conosceva
il suo segreto, decise con grande coraggio di dargli
cristiana sepoltura e suonò le campane per radunare
gente. Vennero tutti e non ci fu difficoltà a trovare anche
i soldi per comperare quattro assi e fare una cassa con
una bella croce sopra.
Il parroco fece il suo bel discorso, insistendo molto
sull’esempio di Gesù che era morto per riparare i peccati
degli altri e sul grande valore della penitenza, scelta
volontariamente e per mezzo della quale anche noi ci
uniamo alla morte di Gesù in riparazione del male. Parlò
anche del premio che ci attende in Paradiso e ricordò la
parabola del povero Lazzaro.
Non aggiunse altro certamente per non tradire il
segreto della confessione. In quei tempi i funerali si celebravano
al tramonto e il corteo era illuminato da tanti
ceri, simbolo della resurrezione e della vita eterna: ogni
partecipante ne portava uno. Lascio a voi immaginare le
battute di spirito volgari che, anche in quella occasione,
gli abitanti del castello ebbero il coraggio di cavar fuori,
seguendo la scena dall’alto della torre.
Poco prima dell’alba, quando ancora tutti dormivano,
le campane della parrocchia si misero a suonare a distesa che pareva la mattina di Pasqua. In campanile
non c’era nessuno… Immaginate lo spavento del parroco
nell’udire quella sveglia anticipata e soprattutto nel
trovare la porta del campanile perfettamente chiusa.
La gente con l’animo agitato accorse fin dalle case
più lontane e tutti si radunarono in chiesa con grande
batticuore. Le campane intanto continuavano a suonare
gioiosamente il loro inno di risurrezione. Il parroco allora
indossò cotta, stola e piviale e fattosi precedere dalla
croce, mosse verso il cimitero, poiché in quella direzione
si vedeva un bagliore riflesso nel cielo, ancora trapunto di
stelle ma già in via di rischiararsi per l’alba ormai vicina.
Un nuovo giorno stava per sorgere e tutti ebbero la
gioiosa sensazione che con il sole anche la loro anima
sarebbe stata illuminata e riscaldata da una nuova luce.
Sulla fossa ancora fresca del poveraccio sepolto la
sera prima, trovarono una lastra di marmo con un nome
che sembrava inciso con caratteri di luce: AGIDE.
Il segreto, che il parroco aveva conosciuto e custodito
nel chiuso del confessionale, si rivelava ora a tutti con
la ricchezza del suo significato e la luce del suo esempio.
Tutti s’inginocchiarono e cantarono il Te Deum. Al
termine anche le campane cessarono il loro inno.
Qualcuno raccontò che la lastra di marmo era così bianca
da sembrare fosforescente e che di notte questo candore
luminescente si vedeva nitido fin dal castello, quasi
volesse essere un continuo richiamo. Neppure questo segno e questi fatti valsero a far cambiare
condotta al padre e ai fratelli di Agide, che liquidarono
il tutto con qualche battuta blasfema.
È proprio saggio il proverbio che ci ricorda come «la
pianta cade dalla parte che pende» e l’altro che conclude:
«si muore come si è vissuti».
Ad uno ad uno, infatti, quando venne la loro ora, se
ne andarono tutti senza prete e senza sacramenti.
Furono sepolti nella grande tomba di famiglia, accompagnati
da commenti di sollievo di quanti malauguratamente
li avevano conosciuti.
La grande pietra scura che ricopriva il loro sepolcro
si spezzava di continuo e per quanto si facesse per ripararla
non era mai possibile vederla intera.
Spesso veniva ritrovata anche spostata e la gente diceva che di notte degli uccellacci scuri e delle ombre
uscivano dalle fessure e volavano sui merli del castello
con stridii lamentosi.
Sembra che si sentano anche oggi, soprattutto nelle
notti senza luna, e qualche scout crede di averli intravisti.
Molti cominciarono allora a pensare che sarebbe
stato meglio spostare la chiesa lontano da quel castello
così triste e maledetto, edificandone una nuova in una
località più comoda e centrale rispetto ai vari borghi.
Passò molto tempo prima che si giungesse ad una
decisione operativa. Ai tempi di Boccia se ne parlava
ancora ma finalmente si arrivò a dare inizio alla costruzione
del nuovo edificio. Quando tutto fu pronto, il parroco
in carica con una grande processione, cui parteciparono
anche gli abitanti dei paesi vicini, trasportò nel
nuovo edificio tutti gli arredi, le statue e il Santissimo
Sacramento.
Nella vecchia chiesa rimasero solo le campane, in attesa
di una impalcatura speciale necessaria per rimuoverle.
Quella notte stessa suonarono ancora a distesa sul
vecchio campanile e la gente da lontano vide un gran
chiarore nel camposanto.
Al mattino molti curiosi accorsero per vedere ciò
che era acccaduto e con grande sorpresa constatarono
che la tomba di Agide era scomparsa.
Il parroco, conoscendo tutte le notizie storiche annotate
nell’archivio, concluse che dopo la partenza di Gesù Eucaristico dalla vecchia chiesa, Agide non aveva voluto
lasciare nemmeno le sue ossa nella zona.
Un’altra versione della leggenda dice che la lapide
di Agide fu impiegata per costruire la mensa del
nuovo altare.
La vecchia chiesa pian piano rovinò e le pietre che si
poterono recuperare furono impiegate per altre costruzioni
e per restaurare, nel secolo scorso, il castello.
Anche il cimitero fu abbandonato e il tempo cancellò
anche lui dal territorio, lasciando solo il ricordo... sfumato
in leggenda.
Non sembra invece che siano sparite le ombre oscure:
nelle notti senza luna volano stridendo e cigolando
attorno alla torre del castello. Ma forse saranno solo il
prodotto della fantasia di qualche scout impaurito.
Nei campi di specializzazioni se ne fa comunque un
gran parlare…